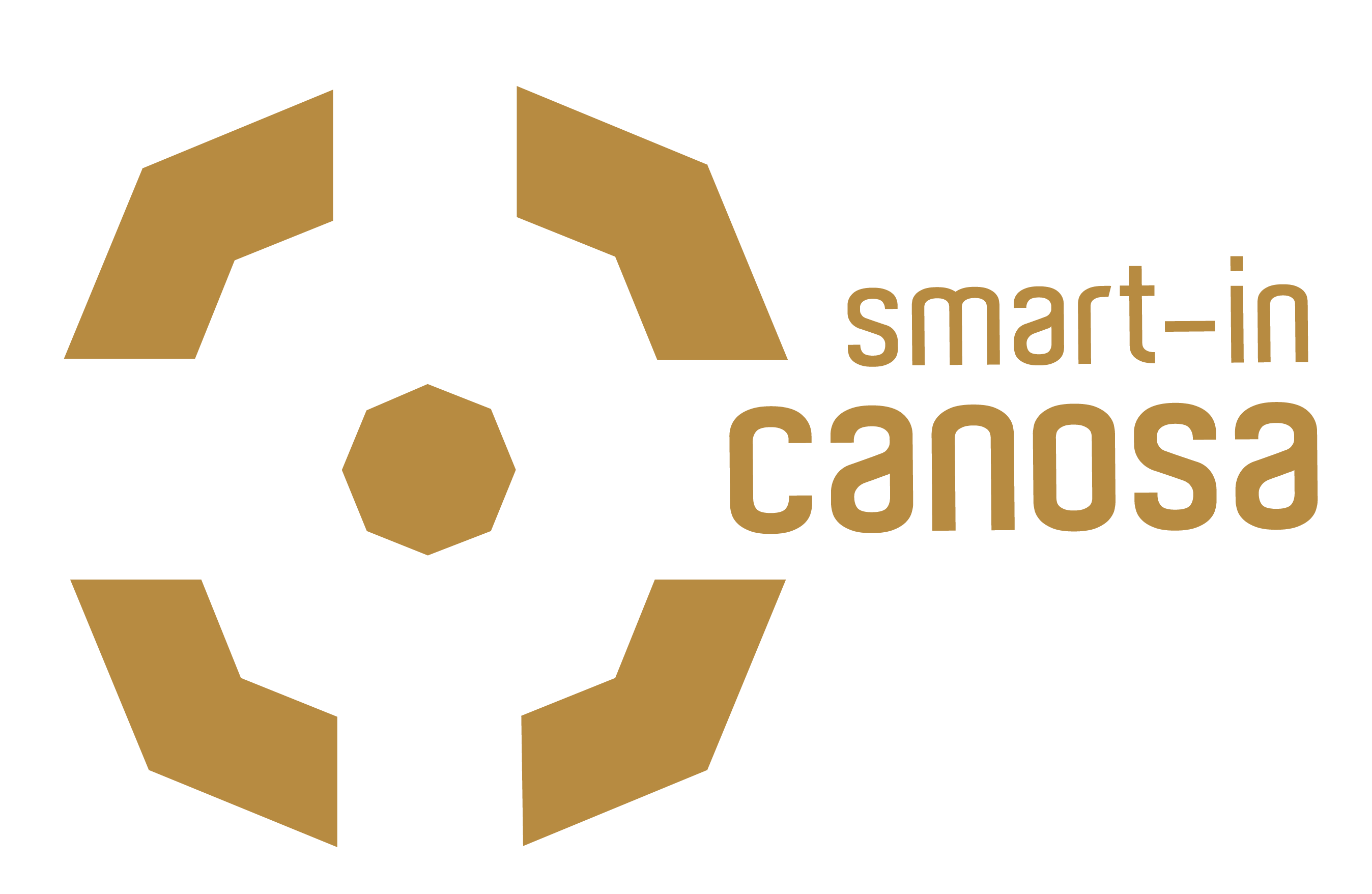Area di San Giovanni
DALLE ORIGINI ALLA TARDA ANTICHITÀ
L’area di piano San Giovanni fu frequentata sin dal IV-III sec. a.C. come zona di sepoltura, trasformandosi in un quartiere residenziale in età romana imperiale. Il momento di maggiore fulgore si ebbe, in ogni caso, nella tarda antichità, quando (tra il IV e V sec. d.C.) il sito fu prescelto per costruirvi la cattedrale, primo edificio di culto della neonata diocesi, tra le più antiche della Puglia, già molto attiva nella prima metà del IV sec. Su questo primo nucleo intervenne poi il vescovo Sabino nel VI sec., promuovendo un imponente restauro e abbellimento della chiesa e la monumentalizzazione dell’intero complesso, con l’erezione del battistero a pianta centrale, tutt’oggi conservato.
PRE-SABINIANA
Età Daunia
La sepoltura Daunia
Le più antica traccia di occupazione del sito è una fossa scavata nella terra, ritrovata al di sotto del battistero tardoantico, contenente tre individui di sesso maschile appartenenti probabilmente ad una fascia sociale agiata, a giudicare dalla qualità delle loro ossa. Non è possibile stabilire se fra loro vi fosse un legame di parentela: due di essi erano trentenni, mentre il soggetto posto al centro aveva tra i 47 e i 49 anni. Soltanto quest’ultimo recava il capo poggiato su una pietra, una sorta di ‘cuscino funebre’, indizio forse della sua maggiore autorità rispetto agli altri due. Il rituale di sepoltura, con tronco supino e gambe contratte (posizione realizzata forse con l’uso di legacci o teli avvolti intorno alle gambe) riporta a pratiche diffuse tra la fine del IV e III sec. a.C., prima cioè che si diffondessero usi più legati alla romanizzazione; del corredo, rimosso dalla tomba già in antico, sono superstiti due frammenti ceramici a vernice nera, appartenenti uno ad una coppa profonda con due anse orizzontali, usata per bere vino (skyphos), l’altro ad una coppetta con una sola ansa. Gli individui erano stati seppelliti con alcuni monili testimoniati da piccole particelle metalliche individuate sui corpi. Nell’area di San Giovanni c’erano forse anche altre tombe di questo tipo. Non è noto al momento se nei pressi delle sepolture sorgessero anche le abitazioni della comunità indigena canosina, come era consueto negli abitati di questo periodo.
Età
Romano-Imperiale
Viabilità da Canosa alla via Traiana e ai villaggi di Canne e Barletta
Lo sviluppo nel tempo del quartiere, non distante dal centro della città, fu certamente assicurato dalla sua prossimità alla via Traiana che passava a Nord e agli assi stradali che collegavano Canosa a due villaggi del suo territorio, di grande importanza per l’economia urbana, Canne e Barletta, quest’ultimo costiero e dotato anche di un porto.
Il laboratorio tessile sotto il battistero
Il pregio decorativo degli ornamenti parietali, unito alla tecnica costruttiva delle murature in grandi blocchi, fa pensare ad un edificio di prestigio, cui si affiancano ambienti adibiti a funzioni di servizio, suggerite dal tipo di pavimentazioni, dalla presenza di una vasca intonacata e, fra i reperti, di numerosi pesi da telaio, aghi crinali, che rimandano all’attività di tessitura, evidentemente praticata al suo interno.
Il quartiere residenziale di età romano-imperiale
In età romana l’area ospitò un quartiere residenziale, di cui gli scavi hanno individuato alcuni resti. Quelli meglio conservati si trovano al di sotto del battistero e delineano lo sviluppo di quattro ambienti, riorganizzati in un secondo momento, dotati di pareti e soffitto rivestiti con intonaco dipinto, pavimenti in signino (cioè in cocciopesto con piccoli inserti di marmo o di tessere musive) e a mosaico di tessere in cotto e inserti di mattoni.

PROGETTO MULTIMEDIA – SMART IN Valorizzazione del Luogo della Cultura: Area del Battistero di San Giovanni con la Basilica di Santa Maria promosso dal Comune di Canosa di Puglia realizzato nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.7